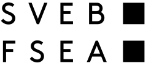L’intelligenza artificiale (IA) interpreta il “cliente difficile”: un progetto pluripremiato ha utilizzato l’intelligenza artificiale come interlocutore per simulare conversazioni con i clienti. Il responsabile del progetto, Martin Berger, sottolinea che l’uso dell’IA non è volto ad automatizzare l’apprendimento, bensì a favorirlo.
Signor Berger, lei ha utilizzato l’IA e la realtà virtuale per un progetto volto a simulare situazioni di comunicazione delicate. Qual è il suo bilancio?
Nel nostro progetto abbiamo sviluppato un sistema di formazione digitale che consente alle persone in formazione nel commercio al dettaglio di esercitarsi in conversazioni difficili con i clienti, tramite lo schermo dello smartphone o in modo immersivo con il visore VR. Invece di dialogare con attori reali, parlano con un avatar cliente gestito dall’IA e poi riflettono sul proprio comportamento comunicativo con un coach virtuale. I primi riscontri di un piccolo studio sul campo sono molto positivi: le persone in formazione hanno percepito le conversazioni come realistiche e utili, soprattutto per prepararsi alle situazioni d’esame. Hanno potuto esercitarsi in un contesto sicuro, commettere errori e imparare direttamente da essi. Mi ha colpito quanto l’applicazione abbia stimolato i partecipanti ad agire. Come insegnante e docente ho visto molte lezioni, ma non ricordo di aver mai assistito a una partecipazione così attiva.
Quali difficoltà e interrogativi ha incontrato?
La sfida più grande non era di natura tecnica, ma riguardava la “messa a punto” dell’effetto pedagogico. Il cliente virtuale a volte reagiva in modo troppo prevedibile. Mancano ancora in parte le emozioni, le reazioni spontanee o i malintesi che si verificano nelle conversazioni reali. Anche il feedback dell’IA era ben strutturato, ma spesso troppo generico nei contenuti. Queste esperienze dimostrano che, affinché l’IA possa essere utilizzata in modo sensato nell’apprendimento, è necessaria una buona progettazione pedagogica. E solleva nuove domande: ad esempio, come combinare il feedback automatizzato con l’accompagnamento umano, in modo che l’apprendimento rimanga personale, anche se l’interlocutore è virtuale?
L’IA è adatta «solo» a questi giochi di ruolo? O si possono immaginare altri impieghi?
No, affatto. I giochi di ruolo sono un punto di partenza naturale, perché l’IA mostra la sua forza dialogica: è in grado di reagire in tempo reale e assumere ruoli diversi. Ma il potenziale va ben oltre. Vediamo grandi opportunità ovunque l’apprendimento possa essere supportato dal feedback, dall’individualizzazione o dalla simulazione, ad esempio nel coaching, nella diagnosi dei processi di apprendimento o nell’allenamento delle competenze decisionali e di problem solving. L’IA può stimolare le persone in formazione in modo mirato senza sovraccaricarle e alleggerire il carico di lavoro degli insegnanti, assumendo compiti di routine e creando più spazio per l’accompagnamento individuale.
Dove vede il maggior potenziale per l’uso dell’IA nella formazione degli adulti in generale?
Nella formazione degli adulti si lavora spesso con gruppi molto eterogenei e tempi di apprendimento limitati. In questo caso l’IA può aiutare a rendere i processi di apprendimento più flessibili e personalizzati. Ad esempio, l’IA può fornire nuove forme di auto-regolazione e riflessione, fungendo da partner di confronto che pone domande e stimola il pensiero. Il vero valore aggiunto non sta quindi nell’automatizzare l’apprendimento, ma nel renderlo più individuale, situazionale e dialogico.
In un sondaggio FSEA svolto presso gli enti di formazione, l’IA è stata utilizzata principalmente per la creazione di materiali didattici. Ha già esperienza in questo campo? Se sì, quale?
Sì, questa è effettivamente una grande tendenza e anch’io utilizzo costantemente l’IA generativa. Ad esempio, per variare automaticamente casi di studio, quiz o copioni per giochi di ruolo. Tali applicazioni possono facilitare enormemente la preparazione. Allo stesso tempo, servono chiari controlli di qualità: i buoni materiali (didattici) non nascono premendo un pulsante, ma dall’interazione tra didattica disciplinare e strumenti di IA. Considero l’IA come una coautrice, utile ma non autonoma.
Si potrebbe dire che l’IA è agli albori: c’è ancora un enorme potenziale inutilizzato o il clamore è eccessivo e potrebbe seguire una fase di disillusione?
Entrambe le cose sono vere in parte. Il clamore è grande e molte delle promesse non sono ancora mature dal punto di vista tecnico o didattico, o probabilmente non si realizzeranno mai nella forma promessa. Allo stesso tempo, nei nostri progetti vediamo che le applicazioni basate sull’IA possono creare un reale valore aggiunto, se integrate in modo intelligente. Non siamo quindi alla fine, ma all’inizio di una curva di apprendimento. La tecnologia evolve rapidamente e con ogni iterazione diventa più credibile, flessibile e controllabile. Sarà fondamentale utilizzarla in modo pedagogicamente sensato.
In che misura cambierà il ruolo di formatrici, formatori e docenti?
Il ruolo di chi forma tenderà ad ampliarsi piuttosto che a ridursi. L’IA può svolgere il lavoro di routine, ma ciò che conta davvero rimane umano: relazioni, motivazione, valutazione, orientamento. In futuro, le formatrici e i formatori diventeranno sempre più accompagnatrici e accompagnatori nell’apprendimento, che utilizzano strumenti basati sull’IA in modo mirato, interpretano criticamente i risultati e moderano i processi di apprendimento. Ciò richiede nuove competenze, ma anche una certa serenità nell’uso della tecnologia. Non lo vedo tanto come una minaccia, quanto piuttosto come un’opportunità per ridefinire la propria professionalità, con più tempo da dedicare all’essenziale: l’apprendimento delle persone.
Martin Berger è docente presso il dipartimento di scuola secondaria II/formazione professionale della PH di Zurigo.
Il progetto Embodied Conversational Agents è stato premiato quest’autunno nell’ambito dell’AI in Education Competition 2025 internazionale a Hong Kong con l’Outstanding Innovation and Creativity Award.